Sezione Locale della Società Psicoanalitica Italiana
Sezione Locale della Società Psicoanalitica Italiana

Presentazione di Patrizia Montagner
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 20 Giugno, pubblichiamo questo articolo per far conoscere il lavoro che Monica Massari sta portando avanti da alcuni anni all’Università di Milano: un progetto* di raccolta di storie dei migranti che raggiungono l’Europa attraverso il Mediterraneo e la Rotta Balcanica.
Descrive in questo articolo alcuni elementi importanti che ha visto più volte ritornare nei loro racconti . Temi come il dolore, la sofferenza, il sentirsi un nulla, la violenza , la delusione, la rabbia e l’odio.
Descrive anche i suoi pensieri su questo e soprattutto esplicita quelle domande che forse anche noi ci facciamo quando ci capita, a volte involontariamente, di imbatterci nel racconto di uno di loro.
Il Mediterraneo e la Rotta Balcanica continuano ad essere molto frequentati, e purtroppo esseri umani disperati continuano a morire, anche se la cosa ormai pare non fare più notizia.
Massari ci ricorda prima di tutto il crimine dell’indifferenza.
Ma ci mostra anche che qualcosa sta cambiando, non in noi, purtroppo, ma nei migranti che stanno lentamente trasformando l’idea di loro stessi, e il vissuto di essere soltanto vittime. Qualcuno si ribella. Qualcuno chiede di essere trattato da umano, Qualcuno pensa anche di avere dei diritti, come umano.
Che senso ha questo? Porterà a dei cambiamenti nella visione sociale della migrazione, nella politica, nel nostro modo di viverli’? Porterà anche noi a farci delle domande e a cercare un senso in questa realtà così vicina a noi?
Mi auguro che la lettura di questo articolo susciti anche in noi interrogativi, dubbi, e soprattutto il bisogno di pensare e ripensare il senso che diamo all’accoglienza del migrante come esperienza che riguarda ciascuno.
*Horizon 2020 project ITHACA Interconnecting Histories and Archives for Migrant Agency: Entangled Narratives Across Europe and the Mediterranean Region (G.A. 101004539)
di Monica Massari
I. C’è un interrogativo che mi accompagna costantemente da quando ho iniziato a occuparmi di storie di donne e uomini migranti, cioè di quelle persone che, a partire da quest’inizio di secolo, si sono trovate ad attraversare le frontiere d’Europa. Sono storie di fughe, vite interrotte, sradicamenti, corpi abusati, memorie ferite. Ma sono, al contempo, storie di sovversione, resistenza, inquietudine, espressione del disperato bisogno di ribaltare la condizione di non-persone a cui sono consegnate le loro esistenze.
La domanda che mi faccio è questa: quale capacità abbiamo di comprendere e accogliere queste storie? Quale ascolto siamo in grado di rivolgere alle voci delle persone che nel corpo e nello sguardo portano i segni della violenza della Storia, e che, attraversando confini, tentano faticosamente di trovare un nuovo orientamento nel labirinto della loro esistenza?
In questi ultimi quindici anni sono tornata spesso a occuparmi dei viaggi dei migranti attraverso il mar Mediterraneo. Si tratta di un fenomeno su cui oramai disponiamo di informazioni, studi, ricerche approfondite, vista anche la visibilità e l’urgenza che l’immigrazione irregolare via mare ha assunto nel dibattito pubblico. Questo è avvenuto soprattutto a seguito dell’aumento del numero dei migranti giunti lungo le coste italiane con l’esplosione della primavera araba e delle rivolte che dalla Tunisia si sono estese in altri Paesi dell’area nord-africana già più di dieci anni fa. Ma poi, più di recente, con l’acuirsi drammatico del conflitto siriano che in questi anni ha prodotto la fuga di oltre cinque milioni di persone per lo più nelle zone circostanti la Siria – prima fra tutte la Turchia – e in misura crescente verso l’Europa.
Sono più di un milione i migranti, in gran parte di origine siriana, ma anche provenienti da Afghanistan, Iraq, Somalia, Eritrea, Nigeria – giusto per citare i principali paesi di origine – che in un solo anno, il 2015, hanno attraversato il mar Mediterraneo, rendendo evidente come la cosiddetta crisi migratoria in Europa abbia in realtà reso manifesta la crisi dell’idea stessa di Europa. Posti di blocco, muri, fili spinati, fossati sono ritornati con violenza a segnare i confini europei. Sono gli stessi potenti, miserevoli simboli dei regimi totalitari del passato. Lungi dallo scomparire, oggi i confini si riproducono senza tregua, si ri-generano. Militarizzazione delle frontiere, detenzione, deportazione, pratiche di respingimento sono divenute le parole-chiave di politiche migratorie orientate in misura crescente verso l’ostilità e il rifiuto nei confronti di chi cerca, legittimamente, un rifugio. Perché accanto a coloro che riescono in qualche modo a giungere in Europa, molti altri, invece, non ce la fanno: si stima che siano circa ventimila coloro che sono morti o dispersi nel Mediterraneo dal 2019 a oggi. Morti lontani, invisibili, ignoti, comparse mute in quel tragico spettacolo del confine che si consuma lungo le frontiere d’Europa. Al punto che il Mediterraneo è stato definito “il confine più letale” attualmente esistente al mondo, quello che genera più morti. Eppure, puntualmente, passata l’ennesima tragedia, tutto è destinato a essere cancellato da uno stato di indifferenza pubblica generalizzata, di anestesia culturale. Anche la possibilità del compianto viene atrofizzata.
Immaginiamo per un attimo che cosa significherebbe vedere adagiati lungo le rive dei fiumi che attraversano le principali città europee questi ventimila corpi e più, invece che nei fondali marini, nelle bare allineate lungo le banchine dei porti o sotto una lapide rudimentale sormontata da un foglietto di carta con scritto “IGNOTO” e la data dello sbarco… Una fila di chilometri di corpi di uomini, di donne, di bambini, con i loro vestiti strappati, gli sguardi attoniti, le mani intrecciate gli uni agli altri, stretti nel tentativo di trovare riparo o salvezza. Accompagnati da pochi bagagli, lì, accanto a loro: fotografie scolorite in abiti di festa, brandelli di lettere, documenti, libriccini di preghiere, il Corano, appunti con indirizzi, numeri di telefono, un glossario bengali-inglese.
Quale volontà, quale possibilità abbiamo di comprendere questa follia della Storia così indissolubilmente avvinta alle esistenze individuali?
II. La necessità di raccogliere informazioni utili a comprendere un fenomeno sociale su cui si dispone di analisi per lo più di tipo istituzionale e su cui non è facile svolgere ricerca empirica diretta, mi ha condotto, in questi anni, a privilegiare fonti orali, storie di vita, narrazioni autobiografiche. Andando a trovare i protagonisti di quelle storie nelle città del Sud dove molti di loro vivono e che mi trovo io stessa a frequentare: a Napoli, nelle campagne calabresi, in alcune cittadine sulla costa meridionale della Sicilia. Questi incontri, che mi hanno consentito di raccogliere informazioni preziose sul funzionamento dell’industria dei viaggi irregolari attraverso il Mediterraneo, mi hanno lasciato con un senso di inquietudine, di spaesamento, di dolore. Era lo spiraglio che queste storie aprivano su universi umani carichi di angoscia e su vissuti densi di umiliazione a lasciarmi un senso di colpa difficile da superare.
L’attraversamento del Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna, affidate alla guida di persone per lo più inesperte, in condizioni di navigazione talvolta estreme, senza alcun equipaggiamento utile a fronteggiare i mille pericoli che il mare potrebbe presentare costituisce l’ultima fase di un viaggio iniziato, talvolta, molto tempo prima. Oltre a coloro che partono dai Paesi più prossimi ai luoghi di imbarco – soprattutto tunisini, egiziani, libici e marocchini – in questi ultimi anni buona parte dei migranti giunti via mare sulle coste siciliane proviene dall’Africa sud-occidentale – soprattutto dalla Nigeria – e dall’Africa orientale, in particolare dalla Somalia e dall’Eritrea. I loro racconti parlano di mesi, talvolta anni, trascorsi in cammino attraverso i meandri di quella geografia parallela, in parte sovrapponibile alle mappe ufficiali, fatta di attraversamenti, soste forzate, soggiorni temporanei in luoghi di frontiera in attesa del passaggio giusto, del denaro necessario, della guida più esperta o, più semplicemente, del momento più propizio a continuare il viaggio. I migranti, affidati alla perizia e, molto meno, alla benevolenza di passeur, dallala (intermediari) e mediatori che offrono a pagamento i propri servizi per accompagnarli lungo tratti più o meno lunghi del percorso che li condurrà verso il luogo d’imbarco, si trovano a sperimentare, durante questa fase del viaggio, situazioni estremamente difficili, spesso ai limiti della tolleranza fisica, e soprattutto psicologica. Nelle conversazioni avute con molti di loro ricorre frequentemente il racconto di violenze, abusi, soprusi esercitati dai vari mediatori contattati dai migranti per percorrere alcune tappe del tragitto, ma anche dalle forze dell’ordine, poliziotti, personale di frontiera incontrati nei vari Paesi attraversati. È oramai risaputo, infatti, come questo mercato parallelo che consente a chi non dispone dei requisiti necessari per giungere in maniera regolare nella cosiddetta Fortezza Europa, opera grazie a un’intricata rete di rapporti reciprocamente vantaggiosi gestita solo in parte da reti criminali. Dall’analisi delle informazioni raccolte emerge come questi viaggi spesso siano resi possibili dai servizi offerti a pagamento da singoli individui che dispongono di particolari know-how, come appunto nel caso dei passeur o degli agenti di viaggio, mediatori in grado di mettere in contatto la domanda con l’offerta, semplici cittadini che offrono alloggi dove ospitare momentaneamente i migranti in fuga o che provvedono a organizzarne il soggiorno – fornendo loro pasti, informazioni, tessere telefoniche con cui chiamare i famigliari in patria –, connazionali dei migranti stessi che risiedono stabilmente nei luoghi di transito e che si offrono come intermediari. Ma anche, come si diceva, poliziotti corrotti, personale di frontiera, funzionari di ambasciate, esponenti delle istituzioni –guardie, direttori di carceri e di altri luoghi di detenzione (e di tortura) presenti in diverse aree della Libia – entrati a far parte, in maniera più o meno organica, del complesso sistema che consente, ad esempio, a una donna partita da uno sperduto villaggio somalo dell’area di Mogadiscio di giungere, dopo cinque, sei, sette o addirittura un anno di viaggio in uno dei porti di partenza situati nella zona di Zuwarah, in Libia, da cui imbarcarsi alla volta dell’Italia
Sia per i migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana che per coloro che provengono dall’area orientale del continente l’attraversamento del deserto per entrare in Libia costituisce indubbiamente una delle fasi più difficili del viaggio. A seconda del denaro di cui si dispone e, dunque, dei servizi che si è in grado di acquistare, l’attraversamento del deserto può richiedere una settimana di viaggio – qualora venga percorso con automezzi – o addirittura anche tre-quattro settimane nei casi in cui se ne percorra una parte a piedi, sempre accompagnati da guide locali e intermediari. Per i migranti si tratta di uno dei momenti di maggiore vulnerabilità a causa delle condizioni particolarmente dure in cui si svolge il viaggio stesso: con un equipaggiamento ridotto al minimo e con scorte di acqua e di cibo quasi sempre insufficienti a fronteggiare contrattempi e ritardi rispetto ai tempi originariamente previsti. Si tratta di un viaggio estremamente pericoloso anche a causa delle continue incursioni da parte di banditi e mercenari che aggrediscono i migranti, sottraendo loro i pochi beni essenziali di cui dispongono.
Molti migranti sono raggirati proprio dagli stessi accompagnatori, come ricorda Hudson, un ragazzo ghanese incontrato a Napoli, che dopo aver viaggiato per due giorni nel deserto, viene abbandonato dalla guida, assieme ad altri compagni suoi connazionali:
[…] Quando l’uomo scappò, seguimmo le orme dei piedi di altre persone… e tutti… alcune persone dicevano: “questa è una via”, altri dicevano: “questa è una via”. Così qualsiasi strada sceglievi, quella che ti sembrava giusta la seguivi. […] Noi seguimmo le orme delle persone, vedemmo altre persone che avevano camminato ed erano morte, molte persone che erano morte sulla via, perché a volte l’acqua che porti finisce e, anche se finisce, devi continuare a camminare e finisci per morire.
L’abbandono, la minaccia costante di ritorsioni violente e punizioni, l’incombenza della morte si ripropongono incessantemente durante tutto il percorso. Letteralmente alla mercé di individui senza scrupoli da cui si dipende totalmente con ben poche possibilità di scelta e in balia di situazioni in cui non si dispone di alcuna capacità di orientamento, questi uomini e queste donne riescono comunque ad attivare forme di resistenza fisica e psicologica inimmaginabili, di cui si trova un’eco nei loro racconti:
Così da quel punto camminai con i miei amici tre giorni – continua la sua storia Hudson. Vedemmo la luna e pensammo che fossero luci, così seguimmo la luna […] se vedi che c’è qualche luce, poi sai dove andare. […] Così noi seguimmo la luna, camminavamo, ma non vedevamo niente, non c’era niente, pensavamo fossero luci e invece era la luna…
La delicatezza struggente di alcune parole, di alcune immagini mi è rimasta impressa in questi anni. La luna, i delfini che accompagnano le piccole imbarcazioni durante il viaggio in mare – e che sono considerati di un buon auspicio – le parole trascritte da un autore anonimo in un glossario bengali-inglese trovato fra i resti di un’imbarcazione approdata a Lampedusa: fiume, stelle, cielo, mare, mondo, poeta, attore, scrivere, conoscenza… e che rivelano un ordine poetico dell’esistenza straordinario e toccante.
III. Per anni queste parole sono rimaste confinate silenziosamente all’interno delle note di campo e dei diari redatti nel corso delle interviste. Per molto tempo ho pensato che fossero destinate a esistere solo nello spazio muto e inquieto del mio ricordo. E lì le tenevo, forse per il timore di avvallare raffigurazioni omologanti di un’umanità dolente, indistinta – i migranti, i sopravvissuti, le vittime – in cui l’accento era sulla loro sostanziale subalternità e su quel tratto universale di vulnerabilità di cui sono, spesso loro malgrado, specchio. Come se fosse pensabile separare i soggetti di quelle narrazioni, i loro vissuti carichi di dolore e violenza dai processi politici, dalle pratiche sociali e dai meccanismi giuridici che avevano prodotto la loro condizione.
Oggi comprendo meglio come la trama che quei racconti faticosamente tentavano di ricomporre, indissolubilmente avvinta alla Storia, non poteva essere disgiunta dal trauma dell’esperienza vissuta. Storie che parlavano di sofferenza, paura, umiliazione, ancora vive nei ricordi o appena percepibili nei lunghi silenzi di cui si componevano le nostre conversazioni e di cui rimane traccia nelle mie trascrizioni: spazi bianchi, puntini di sospensione… Ma quelle erano, al contempo, storie di resistenza, capaci ancora, nonostante tutto, di denunciare, con la forze struggente, autentica e poetica di un racconto sulla propria esperienza drammatica, le implicazioni sociali, politiche ed economiche di tutto quell’orrore, con il passato irrisolto (coloniale) che contenevano e con il presente neoliberista e post-coloniale su cui si dischiudevano.
Questi racconti, accolti il più possibile con rispetto e attenzione, hanno lasciato in me una traccia profonda, come spesso avviene tra chi narra e chi ascolta una storia. Quella relazione, quello spazio di condivisione che i loro racconti hanno costruito parlavano di vite da molti considerate non degne di lutto, vite vissute in una sorta di penombra della vita pubblica, indegne di essere protette e di ricevere riconoscimento umano, e dunque anche giuridico e sociale. Ma le loro vite parlavano anche della mia, della nostra, perché parlavano di giustizia e di ingiustizia, di uguaglianza e di potere. Judith Butler scrive che “per quanto in forme minime e vitali, raccontare e ascoltare una storia sono ancora una maniera per «condurre una vita», poiché attraverso questi atti si afferma che in qualsiasi occasione possiamo riconoscere la vita e la sofferenza dell’altro”.
Trovare un contesto di ascolto che sia disponibile ad accogliere i linguaggi dell’inquietudine, che riesca a sovvertire quella maledizione di essere niente a cui sembrano essere condannati i protagonisti di queste storie, e che possa offrire percorsi che restituiscano alle persone almeno per un momento la loro interezza, forse può far sì che queste testimonianze diventino strumenti per riappropriarsi di una coscienza condivisa e per sovvertire quell’accettazione paralizzata del male a cui una parte dell’Europa sembra essersi consegnata.
Liberamente adattato da M. Massari, La maledizione di essere niente, in Nori, P. (a cura di), Ma il mondo non era di tutti?, Marcos y Marcos, Milano, 2016, pp. 95-111.
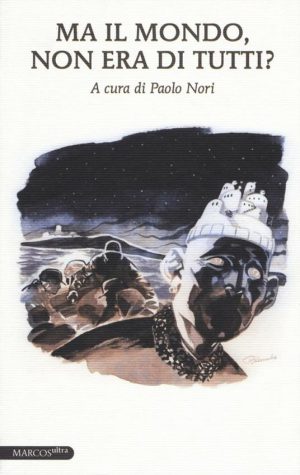
Prof. Monica Massari
Associate Professor of Sociology
Department of International, Legal and Historical-Political Studies
University of Milan
Condividi questa pagina:
Centro Veneto di Psicoanalisi
Vicolo dei Conti 14
35122 Padova
Tel. 049 659711
P.I. 03323130280